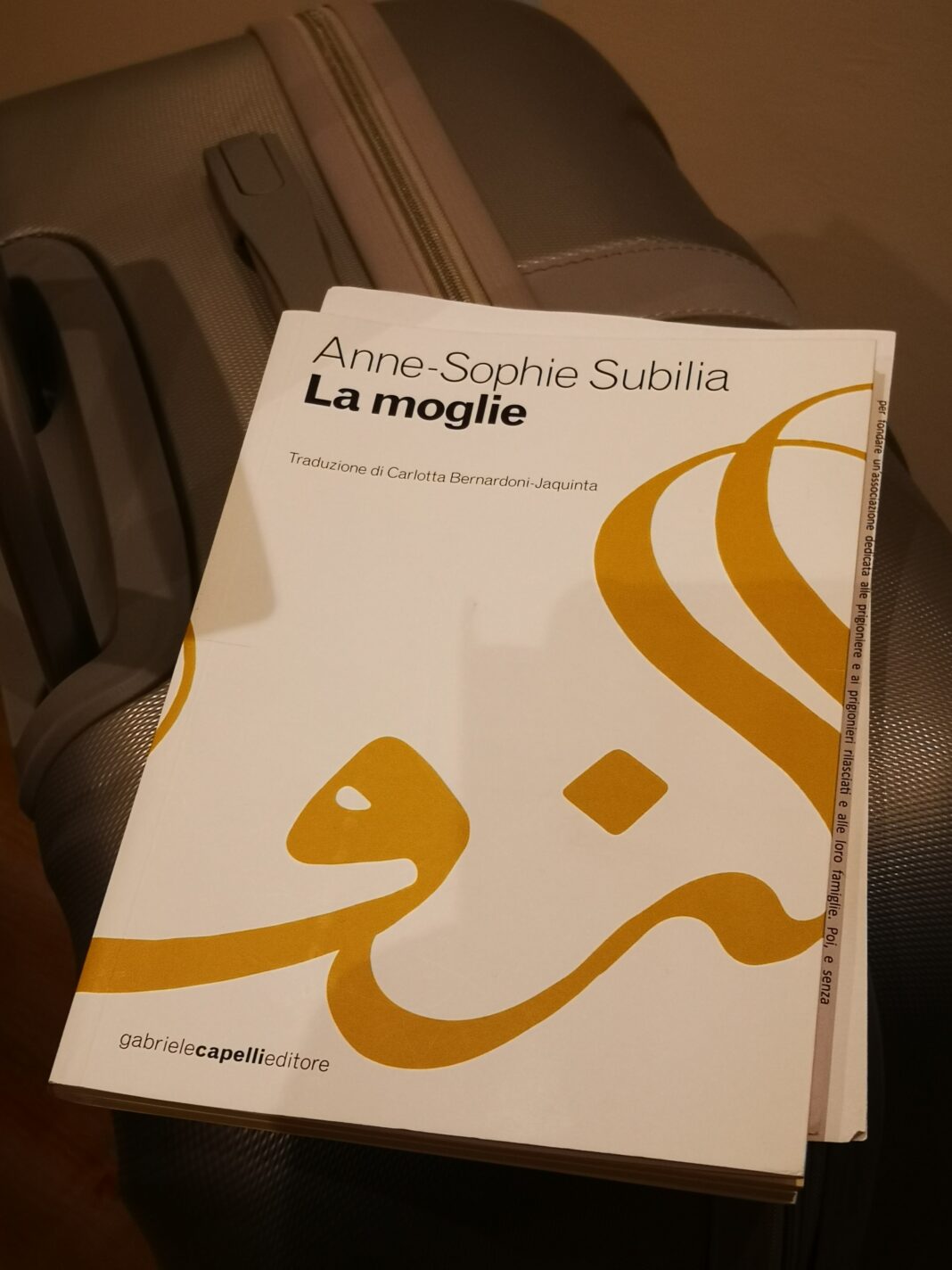Vi proponiamo oggi un libro da mettere in valigia per il prossimo viaggio: scritto dalla pluripremiata romanziera e poetessa svizzera belga Anne – Sophie Subilia, è una storia di solitudine femminile, la storia di una donna che va a Gaza nel 1974 (sette anni dopo l’occupazione israeliana successiva alla Guerra dei sei giorni del 1967, quindi in un periodo cruento paragonabile a quello attuale), al seguito del marito, Vivian, un delegato della Croce Rossa Internazionale, quasi perennemente assente in quanto impegnato al lavoro fino a sera e, a volte, per giorni e giorni in missione come osservatore nelle prigioni israeliane.
La protagonista si chiama Piper ma l’autrice non la chiama mai per nome: la racconta in modo impersonale, lei è “la donna” o, al massimo, “la moglie”, proprio ad indicare la solitudine di una donna che viene identificata in relazione ad un uomo, come moglie del delegato e che si trova comunque a doversi inventare una quotidianità in un paese nel quale non conosce la lingua, tra posti di blocco, improvvise demolizioni di abitazioni povere e una cultura molto lontana dalla sua. Giornate passate in attesa del ritorno del marito, in una casa invasa dalla sabbia e circondata da terreni incolti, raccontate con distacco cronachistico, in una sintassi essenzialmente paratattica. Giorno dopo giorno, la “moglie” imparerà a dedicare il tempo alle piccole cose. Il testo ci racconta in modo lento, con una scrittura asciutta e sequenze brevi, fotografiche, la lentezza delle sue giornate, il senso di solitudine in terra straniera, nel contesto del conflitto israelo palestinese degli anni Settanta, la necessità di stabilire dei legami: è una figura impersonale in cui molte donne possono riconoscersi.
Qualche passeggiata lungo la spiaggia, l’attesa dei racconti del marito, il Beach Club: nella noia generale, Piper è incuriosita dal vecchio giardiniere palestinese Hadj incaricato, con i suoi due figli, di far fiorire il suo giardino nonostante sia dominato dalla sabbia: l’elemento che più ricorre nel libro è proprio quella sabbia che si infila dappertutto, in cucina, dentro il letto così come gli scarafaggi: “L’invasione della sabbia si espande. Più volte al giorno, la donna prende la scopa e passa qualche minuto a scacciarla sommariamente, vale a dire a ributtarla fuori in giardino. Sulle piastrelle della cucina i granelli di sabbia, fini quasi quanto la polvere, assumono una sfumatura violacea. A quel gioco lei perde. E’ obbligata ad accettare la sconfitta. La sua scopa non servirà ad estirpare il fenomeno, non fa che riconfigurare la presenza della sabbia nella casa...”
Piper cerca di stabilire un rapporto con Hadj, pagina dopo pagina, nella profondità dell’ordinario, ma l’anziano signore sfugge ad ogni tentativo di avvicinamento, barricato nel suo senso di rispetto per lei. Piper conosce poi alcune donne della borghesia di Gaza che iniziano ad organizzare delle attività per aiutarla ad integrarsi: Selma, che abita in una delle rare case di notabili di Gaza con tanto di cortile interno e giardino; Naila, un’ interprete che insiste perché vada a fare visita all’ospedale Al – Shifa dove lei lavora come pediatra. E così la moglie del delegato entra nell’ospedale e la sua vita cambia.
Uno degli amministratori israeliani che gestisce l’ospedale, il signor Perez, le chiede se cerca lavoro. “E come per la prima volta, quella domanda la prende in contropiede, arrossisce. Non ha mai pensato di lavorare in ambito ospedaliero”. Esce dall’ufficio tanto confusa a disagio che addirittura cade, andando a sbattere contro un carrello metallico, e si fa male al ginocchio. La aiuta un medico che le propone di visitare la nursery e così la donna inizia un tour dentro l’ospedale dove incontra molte madri, sorelle, nonne che allattano o danno il biberon, si scambiano consigli, condividono le loro esperienze, si aiutano a vicenda mentre i neonati strillano in coro. La donna nota che nella nursery ci sono anche bambini più grandi, qualcuno con il gesso, una fasciatura, le stampelle, il respiratore artificiale. Il dottore si rivolge ai bambini in modo gentile fino a che la donna incontra un piccolo neonato che agita le braccia e piange, da solo, senza nessun adulto a fianco. Si ferma davanti al suo lettino, le lenzuola sono sporche, le viene un conato di vomito. . È una bambina, abbandonata davanti all’ospedale a due mesi di età, senza nome. Si avvicina alla culla di plastica, le mette una mano sulla fronte umida e chiede al personale dell’ospedale cosa intendano fare. “Non lo sappiamo”. Il medico sembra voler continuare la visita ma la donna non si muove. Senza pensarci due volte, scende in città, va a comprare un pacco di pannolini, delle salviette e va ad aiutare quella neonata. E cosi in tutti i giorni a seguire: si prende cura di lei, la lava, la pulisce, mentre la piccola prende confidenza con Piper, affonda la testa nel suo collo mentre respira e fatica. Quando decide di dirlo al marito, ottiene un’unica risposta: se dovessero venire a saperlo al Comitato, lui rischierebbe delle grane.
Quella notte, Piper, da sonnambula, esce in camicia da notte sul tetto terrazzo, a piedi nudi e volteggia direttamente sotto le poche stelle. Aveva forse ragione Mona, l’affascinante psichiatra palestinese incontrata durante un aperitivo dell’agenzia ONU per i profughi palestinesi, nel dire “Un marito? E per fare cosa? Mi renderebbe prigioniera a mia volta”. E infatti Mona, che agli occhi di Piper è l’incarnazione di quella emancipazione femminile a cui lei stessa aspira, ha scelto di non avere marito e figli, di studiare all’università di Aleppo e poi ritornare a casa a fondare un’associazione dedicata ai prigionieri.
Il giorno dopo il marito di Piper, per farle cambiare aria, la porta a Tel Aviv tra le architetture Bauhaus del progetto visionario sionista degli architetti ebrei arrivati dall’Europa con l’ondata migratoria degli anni Trenta. A Tel Aviv, Piper scopre una gioventù ebraica emancipata, donne dagli abiti eleganti e scarpe di vernice, aria di mare, fontane e musei d’arte: un altro mondo rispetto ai check-point israeliani, alle costruzioni mai terminate in strade immerse nella polvere e nella sabbia, con asini e carretti, gli espropri, i controlli, le demolizioni e i rastrellamenti dell’esercito israeliano, l’elettricità che va e viene a seconda di come gli israeliani decidano, la fame e la povertà in cui da decenni è costretta la popolazione. Quando ritorna a Gaza, la donna va subito in ospedale ma non la bambina non c’è più. Come le spiega il dottore, tutti speravano che lei adottasse la bimba ma poiché questo non era accaduto, l’ospedale si era mosso per trovare la famiglia che l’aveva abbandonata. La donna scoppia in lacrime, vuole l’indirizzo della bambina, ma il medico glielo nega: “Forse più avanti potrà chiedere sue notizie, ma non subito: la cosa è troppo fresca, bisogna lasciare che facciano conoscenza. Tra qualche settimana, qualche mese sì”.
La donna entra in crisi, è stufa di tutto, di essere sola, della gente ed anche del marito. Il suo passaporto britannico la mette in crisi con se stessa, si sveglia in piena notte per controllare che gli israeliani non abbiano deciso di abbattere le case dei pescatori suoi amici: non sono stati forse gli inglesi ad occupare quelle terre per poi abbandonarle lasciando un cumulo di macerie? Cerca sostegno nel fratello Sam che atterra a Tel Aviv, da Londra, nonostante sia nel bel mezzo di un divorzio. I giorni con Sam sono giorni di rinascita e di viaggi. Per rallentare ulteriormente il tempo di quella settimana, lei si alza tutti i giorni all’alba anche solo perdersi il suo caffè nero leggendo i romanzi che Sam ha portato da Londra.
Quando Sam riparte, Piper ritorna nella sua quotidianità dove trova l’unico punto di forza nel vedere Hadj che tira l’asino, riempie i sacchi d’acqua e si occupa del giardino. Ma Hadj deve partire perché improvvisamente hanno imprigionato il fratello. E cosi Piper scopre che Hadj aveva una proprietà che si estendeva a perdita d’occhio, con un frutteto ed una sorgente fin sulle colline oltre Gaza e che il fratello era finito in prigione perché si era opposto ai tentativi di espropriazione degli israeliani. Lo Stato di Israele lo aveva accusato facendone un indiziato, il miglior modo per mettere in ginocchio la sua famiglia. La sua proprietà ora è frazionata e recintata col filo spinato. Hadj per ottenere giustizia aveva tentato le vie legali e dopo la sconfitta in tribunale si era dedicato a fare il giardiniere di Piper. Nonostante tutto, Vivian riesce ad aiutarli e il giardino curato da Hadji fiorirà, segno di speranza e di rinascita: “I frutti della passione sono maturi. Durante la notte li si sente cadere ai piedi dell’albero… è sul punto di svegliare Vivian per vivere quel momento insieme a lui…”.
Il libro si è aggiudicato, a ragione, il Premio Svizzero di Letteratura di quest’anno. In Italia è uscito il 23 ottobre scorso per Gabriele Capelli editore, con la traduzione di Carlotta Bernardoni-Jaquinta.
Anna Maria De Luca